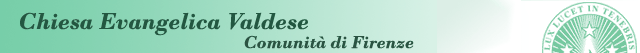 |
Torna
alla Home page |
|
Un "de profundis" per il
protestantesimo?
Seguendo un master postuniversitario su Bibbia e cultura europea, mi è capitato di sentire, da parte di uno dei più importanti teologi cattolici italiani, il prof. Giuseppe Angelini, della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, alcune considerazioni sul Protestantesimo che vado a riassumere. Il prof. Angelini sostiene che il Protestantesimo, più del Cattolicesimo, rischia la propria dissoluzione, sia per effetto della sua disseminazione (per cui molte chiese, specialmente quelle di matrice congregazionalista, hanno la tendenza a crearsi ciascuna la propria ortodossia), sia per la carenza di pratica pastorale (l’esempio più macroscopico è l’assenza della confessione) e di attenzione alla prassi cristiana nella vita quotidiana. Il Cattolicesimo invece, specialmente in Italia, ha avuto e ha una solida consistenza antropologico-culturale. Certo esiste il rischio di un Cattolicesimo civile, ma questa deriva è bilanciata dalla legge morale della vita personale. Mi piacerebbe sentire un Suo parere su tali considerazioni. Più nel dettaglio: è reale il rischio di una dissoluzione del Protestantesimo? Nella temperie postmoderna, il Protestantesimo ha ancora qualcosa da dire? I discorsi che risuonano da tanti pulpiti e da alcune organizzazioni ecumeniche non corrono spesso il rischio di essere terribilmente simili a quelli che vengono pronunciati dalle agenzie dell’Onu e da qualche Organizzazione non governativa? Ma la domanda di fondo è: in quanto protestanti come possiamo dire oggi il nesso tra la fede e le forme dell’agire evitando di scadere, da una parte, in un moralismo spiritualizzante e, dall’altra, in un esasperato individualismo che fa della coscienza del singolo il giudice ultimo dell’agire? Perché, certo, le opere della legge non salvano (Galati 2, 16 e Romani 3,20), ma la legge non è stata abolita (Matteo 5, 17). Luciano Zappella – Bergamo Le
domande poste da questa lettera sono tante e di tale peso che non
è
possibile rispondere a tutte in una volta sola. Le domande sono
quattro. Oggi risponderò alle prime due, la
volta prossima alle
altre
due.
Come si vede, non sono domandine da nulla. Prima di tentare una risposta, devo fare una premessa: faccio fiducia al nostro lettore di aver riassunto fedelmente il pensiero del prof. Angelini. È infatti sempre imbarazzante pronunciarsi sul pensiero di una persona riferito da un altro: anche in un resoconto il più possibile obbiettivo possono annidarsi, senza che lo vogliamo, piccole parzialità o imprecisioni che modificano, anche se di poco, il pensiero di cui intendiamo rendere conto. Sperando che questo non sia il caso e supponendo dunque una sostanziale fedeltà del «riassunto» dell’ascoltatore rispetto al discorso del professore, mi accingo a rispondere. 1. Secondo il prof. Angelini il rischio di dissoluzione storica del protestantesimo sarebbe dovuto principalmente a due ragioni: la prima sarebbe la sua «disseminazione», la seconda una «carenza di pratica pastorale», che a sua volta sarebbe bene illustrata dalla «assenza della confessione». Ora, queste due ragioni mi sembrano davvero poco probanti. [a] Esaminiamo anzitutto la prima. Che la «disseminazione» (forse la parola esatta era «frammentazione») conduca alla dissoluzione di una comunità religiosa e, in genere, di un gruppo sociale, è contraddetto tra l’altro proprio della storia antica e recente del cristianesimo. A esempio, nell’XI secolo, la divisione tra Oriente e Occidente cristiano – ciascuno diventato alfiere e geloso custode della propria ortodossia – non ha indebolito né l’uno né l’altro, e tanto meno li ha avviati verso la loro dissoluzione, al contrario li ha obbligati a meglio definire la loro identità e ad approfondire le ragioni delle loro scelte rispettive. Nel XVI secolo la divisione tra protestantesimo e cattolicesimo romano non ha debilitato né l’uno né l’altro, al contrario ha determinato una sorta di rinascita globale del cristianesimo occidentale, sia pure in un quadro di reciproco antagonismo. Nel nostro tempo, per fare un altro esempio, il movimento pentecostale è cresciuto tumultuosamente si può dire in tutto il mondo, pur attraverso un processo di diffusa frammentazione (in parte anche dottrinale), che però non lo ha certo privato di vitalità e forza d’espansione. Se poi il termine «disseminazione» va inteso nel suo significato proprio di diaspora, non risulta affatto che la diaspora contenga in sé un germe di dissoluzione. Il cristianesimo dei primi secoli non era altro che una grande diaspora sparsa per tutto il vasto impero romano, eppure – come ognuno sa – quella disseminazione cristiana s’è rivelata, alla fine, più forte dell’impero romano stesso. E oggi la maggioranza delle chiese presenti nei vari continenti del mondo sono sempre di più chiese di diaspora, persino nei paesi di antica tradizione cristiana. C’è indubbiamente un calo numerico che, in misure variabili, riguarda oggi tutte le cosiddette «chiese cristiane storiche», ma non mi sembra che questo comporti, a livello mondiale, un diminuito dinamismo del cristianesimo nel suo insieme. Insomma: la «disseminazione», intesa sia come frammentazione, sia come diaspora, non mi sembra essere il preludio della «dissoluzione» del protestantesimo. [b] La seconda ragione sarebbe «la carenza di pratica pastorale» illustrata dalla «assenza della confessione» nel protestantesimo. Evidentemente il prof. Angelini confonde la confessione con il confessionale e identifica la confessione dei peccati con la confessione auricolare dei medesimi. Il protestantesimo ha abolito il confessionale e la confessione auricolare (che come è noto non esisteva nel cristianesimo dei primi secoli e cominciò a essere praticata non prima del VII secolo), ma non ha affatto abolito la confessione. Anzi, le ha dato un posto di assoluto rilievo nel culto pubblico domenicale, come sanno tutti coloro che lo frequentano. Ha però abolito, come ho appena detto, la confessione auricolare, e ci si può naturalmente interrogare sulla bontà di questa decisione. Lutero avrebbe voluto mantenerla. In diversi momenti della sua vita si è sempre pronunciato a favore della confessione privata dei peccati, davanti a un ministro o anche – egli scrive – «di fronte a un fratello» (così, a esempio, nel Grande Catechismo del 1529). La confessione dei peccati nel culto pubblico deve restare, ma non sostituire quella privata che, secondo Lutero, è un bene prezioso per ogni cristiano. L’unica condizione è che sia libera, non venga cioè imposta alle coscienze come un obbligo, «un insopportabile fardello», e anche, sovente, una vera «tortura dell’anima». Questa libertà però, dice Lutero, può essere proprio quella di ricorrere alla confessione privata, «quando qualcosa di particolare ci agita o ci tenta» e abbiamo dei dubbi, o dei rimorsi per qualche colpa segreta, o un’inquietudine, o un turbamento interiore. Allora, liberamente (e non perché costretto da una legge) il cristiano si rivolgerà a un fratello o a un ministro, e gli confiderà la sua pena, o angoscia, per ricevere «come un mendicante» la parola liberatrice del perdono, dell’assoluzione, della grazia – una parola che ci raggiunge «come un meraviglioso, grande tesoro, che dev’essere accolto con ogni onore e gratitudine». Lutero purtroppo non è stato ascoltato e la confessione privata, da fratello a fratello (o sorella), o da fratello a pastore (o pastora), pur non essendo del tutto assente, non è comunemente praticata nella cristianità evangelica. Questo fatto può costituire un deficit effettivo nella vita delle persone e della comunità, non tale però da determinare (con altri fattori) la «dissoluzione» del protestantesimo. Se così fosse, il protestantesimo avrebbe dovuto dissolversi da moltissimo tempo, e questo non è accaduto. Senza contare poi che ci sono molte grandi religioni, come l’ebraismo e l’islam (ma credo anche il buddhismo e le religioni orientali) che prosperano da millenni senza confessione auricolare. Fatta questa precisazione, ci si può e deve chiedere se però non ci sia realmente nel protestantesimo odierno, indipendentemente dalla confessione privata dei peccati, una «carenza di pratica pastorale». A mio giudizio c’è, ma non per il motivo indicato dal prof. Angelini, bensì perché quella che un tempo si chiamava «cura d’anime» non sembra più essere la priorità del ministero di non pochi pastori, che si occupano di molte cose relative alla vita della chiesa, ma troppo poco delle anime, con grave danno, alla lunga, per la loro salute spirituale. Non so quale sia, in proposito, la situazione nella chiesa cattolica, ma temo che anche lì, malgrado la presenza del confessionale e la pratica della confessione auricolare, la situazione non sia molto migliore. Ci si può anzi chiedere se il confessionale sia davvero lo strumento appropriato per una cura d’anime che non punti solo a tranquillizzare le coscienze, ma al contrario a svegliarle e renderle inquiete «a salute», favorendone la crescita. Ma è vero che il cattolicesimo «specialmente in Italia ha avuto ed ha una solida consistenza antropologico-culturale», che lo mette al riparo dal rischio di dissoluzione? Credo che sia vero, come è vero che il cattolicesimo resiste in generale meglio del protestantesimo all’erosione esercitata dalla secolarizzazione sul corpo sociale della chiesa. È un fatto che la pratica religiosa nei paesi di tradizione cattolica è oggi mediamente superiore a quella che si registra nel paesi di tradizione protestante. Questo però non è una novità: il protestantesimo ha, per così dire, una congenita vocazione secolare e non identifica il rapporto con Dio con la pratica religiosa. C’è un culto a Dio che si può rendere laicamente, nella profanità dell’esistenza quotidiana, e non necessariamente in termini liturgici nelle assemblee cultuali comunitarie. Bisognerebbe poi esaminare più da vicino questa «solida consistenza antropologico-culturale» del cattolicesimo che indubbiamente esiste, e vedere che cosa la costituisce. Ma non lo possiamo fare in questa sede. Un rischio imprevedibile Legati
a filo doppio [b] Il futuro del protestantesimo (ma anche del cristianesimo) non dipende dalla sua «consistenza antropologico-culturale» che può essere più o meno «solida», e neppure dalla sua maggiore o minore «fragilità sociologica», ma unicamente dalla fede. Lo dice bene il profeta Isaia: «Se non avete fede, certo, non potete sussistere» (7, 9). E il Salmista, rivolto a Dio, dichiara: «Quelli che s’allontanano da Te, periranno» (73, 27). Il rischio della dissoluzione, dunque, c’è, eccome. Se si dissolve la fede, si dissolve la chiesa… Se si dissolvono la speranza e l’amore, si dissolve la chiesa, di qualunque tipo essa sia. Non tutto quello che si presenta come chiesa, lo è realmente, secondo le parole di Isaia riprese da Gesù: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me» (Matteo 15, 8). Ma se la chiesa è quella comunità nella quale le tre «cose che durano», cioè fede, speranza e amore, prendono corpo, allora anch’essa dura e durerà, fino alla venuta del Regno. Tratto dalla rubrica "Dialoghi
con Paolo Ricca" del settimanale Riforma del 4 maggio
2007 3. Alla domanda se oggi il protestantesimo abbia «ancora qualcosa da dire» risponderò ripetendo quanto ho scritto la volta scorsa, e cioè che mi riconosco perfettamente nell’affermazione di Paul Tillich contenuta in un saggio ormai vecchiotto (è del 1928!), ma per nulla invecchiato, intitolato Il messaggio protestante e l’uomo di oggi (si trova nel già citato Era protestante, della Claudiana), secondo la quale «il protestantesimo è anche e anzitutto cristianesimo». Chiedersi quindi se il protestantesimo abbia ancora qualcosa da dire equivale a chiedersi se il cristianesimo abbia ancora qualcosa da dire. Se il cristianesimo non ha più nulla da dire all’uomo d’oggi, allora non ce l’ha neppure il protestantesimo. Se invece il cristianesimo ha ancora qualcosa da dire all’uomo d’oggi, allora ce l’ha anche il protestantesimo. Abbiamo dunque ancora, come protestanti, qualcosa da dire? Certo che ce l’abbiamo, prima di tutto come cristiani, e poi come protestanti. Abbiamo tutto da dire, e questo tutto è – come sappiamo – una cosa sola: Gesù di Nazareth, la sua storia nella quale è segretamente iscritta ogni storia umana, la sua morte nella quale, come dice la Scrittura, siamo «stati battezzati» e «morti al peccato» (Romani 6, 2. 11), la sua risurrezione nella quale siamo stati resi «viventi a Dio», affinché «camminassimo in novità di vita» (Romani 6, 11. 4), la sua ascensione nella quale siamo «trasportati nel suo regno» (Colossesi 1, 10), la sua seconda venuta nella quale sarà «reso manifesto quel che saremo» (I Giovanni 3, 2). Questo è l’Evangelo, la «vera luce che illumina ogni uomo» (Giovanni 1, 9). Abbiamo tutto questo da dire. Abbiamo da dire anche l’insegnamento di Gesù: il Sermone sul monte (per cercare di metterlo in pratica nacque, tra l’altro, il movimento valdese), i discorsi critici e le insuperabili parabole del Regno – quel Regno che, con la sua giustizia, è da cercare prima di ogni altra cosa. Abbiamo da dire le sue guarigioni, il suo essere-per-gli-altri, la sua passione e compassione, la sua libertà e umanità. Quante cose abbiamo da dire! Il problema non è se abbiamo qualcosa da dire, ma se abbiamo la fede, la forza (interiore) e l’autorità per dirla. Sia chiaro: non è facile essere cristiani. Le nostre chiese si chiamano «evangeliche», ma mi chiedo fino a che punto siano davvero uno specchio attendibile dell’Evangelo. Non portiamo forse un nome più grande di noi? Non abbiamo forse, davanti a Dio (e anche agli uomini), più ragioni di umiliazione che di vanto? I motivi
principali [a] Il primo è che il magistero cattolico – quello del papa e della gerarchia – trasmette al popolo italiano un messaggio che, pur parlando anche di Cristo e del Dio della fede cristiana, spesso purtroppo non è condivisibile da chi, come noi, comprende altrimenti l’Evangelo e cerca anche di testimoniarlo altrimenti. È vero che ci sono non pochi ottimi sacerdoti (potrei fare nomi e cognomi) che nelle loro parrocchie annunciano davvero l’Evangelo nel senso migliore del termine. Ma purtroppo non è la loro voce quella che il popolo italiano ode come «parola cristiana», bensì quella dei vertici ecclesiastici romani, enfatizzata dai mezzi di comunicazione di massa. C’è spesso una notevole differenza tra questa parola della chiesa e la parola di Dio. Intendiamoci: a me non piace criticare gli altri, avendo abbastanza da fare a criticare me stesso. Neppure sto affermando implicitamente che le nostre chiese siano realmente all’altezza del loro compito, che è di comunicare «non solo con la lingua, ma a fatti e in verità» (I Giovanni 3, 18), quella parola di Dio secondo la Scrittura, che è la vita e la sostanza della chiesa e che tutto sommato, malgrado le innumerevoli chiese in cui ogni domenica si legge anche la Bibbia, resta purtroppo poco annunciata agli Italiani e da loro poco conosciuta. Da un lato, c’è realmente, oggi in Italia, «la fame e la sete di udire le parole dell’Eterno» (Amos 8, 11), e dall’altro c’è un grande deficit di annuncio cristiano, malgrado la «moltitudine delle parole» (Matteo 6,7) pronunciate dalle chiese. Abbiamo qualcosa da dire, come protestanti (oltre che come cristiani), se siamo in grado di contribuire, almeno in piccola parte, a diminuire quel deficit. Se poi dovesse accadere, come il nostro lettore afferma, che dai pulpiti delle nostre chiese risuonino discorsi «terribilmente simili» ai proclami dell’Onu o di qualche Onlus, questo può significare due cose: o che la nostra predicazione si è profondamente secolarizzata perdendo, nella sostanza se non nella forma, il suo sapore evangelico ed essendo quindi «gettata via» dagli uomini (Matteo 5, 13), oppure, al contrario, che i discorsi dell’Onu hanno acquistato forse senza accorgersene) una sostanza evangelica, pur nella loro forma secolare, così «muovendo a gelosia» le chiese (Romani 11.11) e dimostrando ancora una volta che «i figli di questo secolo, nella relazione con quelli della loro generazione, sono più accorti dei figli della luce» (Luca 16, 8). Di queste due ipotesi è più probabile che sia vera la prima, ma sarebbe bello se si avverasse la seconda. Pluralità Fede e
azione Paolo
Ricca pastore e professore emerito della Facoltà Valdese di
Teologia di Roma
|